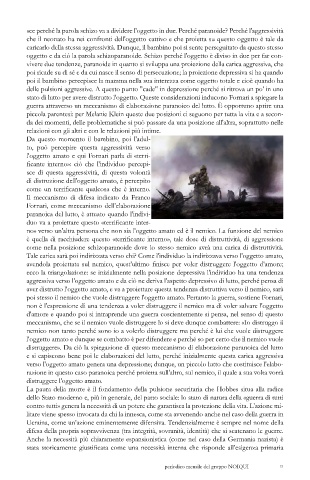Page 21 - RIVISTA NOIQUI GIUGNO 2023
P. 21
luIgI pIsTOnE
Perché la guerra? sce perché la parola schizo va a dividere l'oggetto in due. Perché paranoide? Perché l'aggressività
che il neonato ha nei confronti dell'oggetto cattivo e che proietta su questo oggetto è tale da
caricarlo della stessa aggressività. Dunque, il bambino poi si sente perseguitato da questo stesso
"La psicoanalisi della guerra" è il titolo del libro di Franco oggetto e da ciò la parola schizoparanoide. Schizo perché l'oggetto è diviso in due per far con-
Fornari, pubblicato nel 1964 che, in piena guerra fredda vivere due tendenze, paranoide in quanto si sviluppa una proiezione della carica aggressiva, che
e minaccia atomica, aveva definito la guerra come una poi ricade su di sé e da cui nasce il senso di persecuzione; la proiezione depressiva si ha quando
«elaborazione solo paranoica del lutto». Mentre il lutto poi il bambino percepisce la mamma nella sua interezza come oggetto totale e cioè quando ha
implica un dolore e uno sconforto profondi legati alla delle pulsioni aggressive. A questo punto "cade" in depressione perché si ritrova un po' in uno
perdita di un oggetto amato (una persona cara, un ide- stato di lutto per avere distrutto l'oggetto. Queste considerazioni inducono Fornari a spiegare la
ale, un territorio, eccetera) e si configura come il diffi- guerra attraverso un meccanismo di elaborazione paranoico del lutto. È opportuno aprire una
cile e tortuoso lavoro della sua elaborazione simbolica, piccola parentesi: per Melanie Klein queste due posizioni ci seguono per tutta la vita e a secon-
la paranoia, al contrario, è un modo per rigettare sullo da dei momenti, delle problematiche si può passare da una posizione all'altra, soprattutto nelle
straniero o sul nemico la responsabilità di questa perdi- relazioni con gli altri e con le relazioni più intime.
ta al fine di negarne l’esistenza. Esemplare è l’analogia, prelevata dalla ricerca etnologica sulle Da questo momento il bambino, poi l'adul-
tribù primitive, proposta da Fornari: se accade che in una tribù muoia improvvisamente il figlio to, può percepire questa aggressività verso
del re, anziché elaborare questo lutto atroce, psichicamente indigeribile, si preferisce scatenare l'oggetto amato e qui Fornari parla di «terri-
una guerra contro la tribù confinante attribuendo al suo sciamano la responsabilità di quella ficante interno»: ciò che l'individuo percepi-
morte. sce di questa aggressività, di questa volontà
Ci si limiterà a una presentazione molto rapida dell'idea di Fornari che spiega i momenti di ciò di distruzione dell'oggetto amato, è percepito
che porta alla guerra e come poi cercare di porre fine a essa perseguendo la pace. In fondo For- come un terrificante qualcosa che è interno.
nari riprende quello che sosteneva Freud e cioè che la pulsione all'opera quando c'è una guer- Il meccanismo di difesa indicato da Franco
ra è una pulsione di morte. Fornari certamente riprende questo concetto mettendo l'accento Fornari, come meccanismo dell’elaborazione
sull'angoscia della morte stessa che si appropria soprattutto dell'angoscia delle persone che si paranoica del lutto, è attuato quando l'indivi-
amano. Nelle riflessioni di Freud sulla guerra e sulla morte pubblicate nel 1915, nel drammatico duo va a proiettare questo «terrificante inter-
momento legato allo scoppio della Prima guerra mondiale, è chiaro come il punto di partenza no» verso un'altra persona che non sia l'oggetto amato ed è il nemico. La funzione del nemico
sia costituito dalla coincidenza che egli stabilisce tra lo straniero e il nemico. Si è di fronte a una è quella di racchiudere questo «terrificante interno», tale dose di distruttività, di aggressione
coincidenza non solo storica ma ontologica; nella concezione freudiana in questa coincidenza come nella posizione schizoparanoide dove lo stesso nemico avrà una carica di distruttività.
si rivela una verità fondamentale che caratterizza la forma umana della vita: il mondo straniero, Tale carica sarà poi indirizzata verso chi? Come l'individuo la indirizzava verso l'oggetto amato,
«fonte di enormi quantità di stimolazioni», non può che essere avvertito dall’apparato psichi- avendola proiettata sul nemico, quest'ultimo finisce per voler distruggere l'oggetto d'amore;
co come un fattore di perturbazione, come una minaccia nei confronti della sua inclinazione ecco la triangolazione: se inizialmente nella posizione depressiva l'individuo ha una tendenza
rigidamente omeostatica. Per questo, se continuiamo a seguire Freud, «l’odio è più originario aggressiva verso l'oggetto amato e da ciò ne deriva l'aspetto depressivo di lutto, perché pensa di
dell’amore» in quanto l’odiato, l’estraneo e il nemico sono, nel loro fondo, la stessa cosa. La aver distrutto l'oggetto amato, e va a proiettare questa tendenza distruttiva verso il nemico, sarà
tendenza primaria dell’umano non può non essere paranoica: il mondo in quanto fonte di sti- poi stesso il nemico che vuole distruggere l'oggetto amato. Pertanto la guerra, sostiene Fornari,
molazioni ingovernabili appare prima di tutto come una minaccia per il funzionamento dell’ap- non è l'espressione di una tendenza a voler distruggere il nemico ma di voler salvare l'oggetto
parato psichico. Di qui, seguendo le “orme” di Freud, il paradosso per il quale la “protezione” d'amore e quando poi si intraprende una guerra coscientemente si pensa, nel senso di questo
dagli stimoli conta molto di più della loro “recezione”. In gioco è quella che Freud definisce meccanismo, che se il nemico vuole distruggere lo si deve dunque combattere: «Io distruggo il
l’ambivalenza fondamentale che caratterizza i nostri rapporti con il prossimo: Eros sospinge nemico non tanto perché sono io a volerlo distruggere ma perché è lui che vuole distruggere
verso l’Altro, ma l’Altro in quanto straniero è vissuto come una minaccia incombente. Una am- l'oggetto amato e dunque se combatto è per difendere e perché so per certo che il nemico vuole
bivalenza che contraddistinguerebbe persino le relazioni con l’altro più prossimo (con i propri distruggere». Da ciò la spiegazione di questo meccanismo di elaborazione paranoica del lutto
cari). e si capiscono bene poi le elaborazioni del lutto, perché inizialmente questa carica aggressiva
Fornari spiega quali sono i momenti inconsci che spingono le persone a intraprendere e a per- verso l'oggetto amato genera una depressione; dunque, un piccolo lutto che costituisce l'elabo-
seguire una guerra. Per sviluppare quest'idea si appoggia alla teoria di Melanie Klein, una delle razione in questo caso paranoica perché proietta sull'altro, sul nemico, il quale a sua volta vorrà
rare psicanaliste che ha spiegato molti aspetti dello sviluppo del bambino tenendo conto della distruggere l'oggetto amato.
presenza della pulsione di morte. Le posizioni sono due: schizoparanoide e depressiva. Nella La paura della morte è il fondamento della pulsione securitaria che Hobbes situa alla radice
posizione schizoparanoide il neonato, che ha il piacere di prendere il seno materno, manifesta dello Stato moderno e, più in generale, del patto sociale: lo stato di natura della «guerra di tutti
due tendenze: una piacevole di voler possedere il seno come momento per soddisfare un bi- contro tutti» genera la necessità di un potere che garantisca la protezione della vita. L’azione mi-
sogno ma anche come bisogno piacevole della pulsione sessuale, come sosteneva Freud. Nel litare viene spesso invocata da chi la innesca, come sta avvenendo anche nel caso della guerra in
contempo il neonato ha anche delle tendenze aggressive, distruttive nei confronti del seno: lo Ucraina, come un’azione eminentemente difensiva. Tendenzialmente è sempre nel nome della
vuole mangiare, distruggere. Per far convivere queste due tendenze sullo stesso oggetto, sostie- difesa della propria sopravvivenza (tra integrità, sovranità, identità) che si scatenano le guerre.
ne Klein, il neonato va a dividere il seno in uno buono e in uno cattivo. In questo caso si capi- Anche la necessità più chiaramente espansionistica (come nel caso della Germania nazista) è
stata storicamente giustificata come una necessità interna che risponde all’esigenza primaria
20 periodico mensile del gruppo NOIQUI periodico mensile del gruppo NOIQUI 21